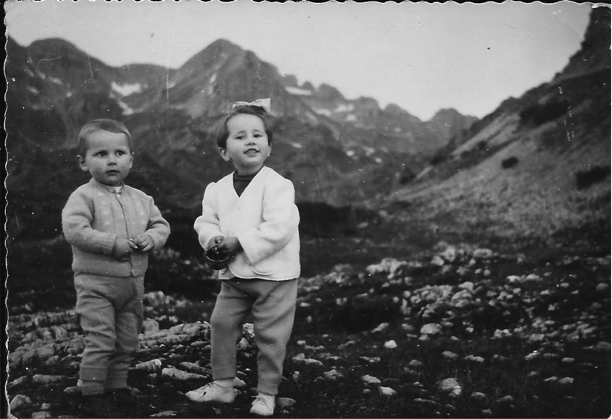![]()
Madonna della Lobbia a Campofontana- Selva di Progno
![]()
![]()
Testimonianze della religiosità in Lessinia
PARROCI DEI LESSINI ORIENTALI
Don Giuseppe Padovani era il Parroco di Selva di Progno, in provincia di Verona, nell’alta Val d’illasi. Nel periodo dell’occupazione nazista dopo l’8 settembre 1943, si è prodigato sempre tenacemente per evitare l’internamento dei suoi parrocchiani in Germania. Qualche volta vi è riuscito. Nell’immediato dopoguerra si univa ai disoccupati che andavano a Verona per reclamare lavoro al Prefetto. Una volta si è sollevato la veste per mostrare i pantaloni da tedesco che aveva sotto. “Ecco com’è ridotto il parroco del capoluogo. Immagini la miseria degli altri.” Era un accanito fumatore di nazionali senza filtro. Nel suo piccolo studio la scrivania era stracolma di libri in ordine, si fa per dire, sparso. Un’aquila impagliata se ne stava tranquilla in un angolo sopra un trespolo incurante della nube che aleggiava nell’aria. Se fosse stata viva sarebbe morta affumicata. Le sue prediche erano piuttosto lunghe. Quando pensavi che la conclusione stava per venire aggiungeva altri periodi con codazzi di subordinate. Aveva retto la parrocchia per oltre trent’anni. Più volte erano giunte in curia delle lamentele per farlo trasferire. “Se volete che mi mandino via sbagliate sistema” diceva. “ Dovete parlare bene di me, perché mi assegnino una sede migliore.” Le suore orsoline dell’asilo parrocchiale preferivano confessarsi dal parroco di Badia Calavena che giungeva settimanalmente con il calesse trainato da una cavallina che legava all’inferriata della scuola materna accanto alla chiesa.
Anche alcune donne del paese approfittavano della presenza del prete di Badia per confessarsi. Successe una volta che l’animale, slegatosi, si incamminasse sulla via del ritorno. “Sior Ansiprete, la cavalina sta andando via”, comunicò un ragazzino al sacerdote che interruppe l’assoluzione per rincorrere la cavallina. Riassicuratala all’inferriata completò la benedizione. I colombi aumentati di numero danneggiavano il tetto della chiesa spostando le tegole. Allora arrivava a decimarli il parroco di Santa Trinità, piccola frazione del Comune di Badia appollaiata sul versante occidentale della valle, con il suo fucile da caccia.
Un progetto approvato dal ministero dei lavori pubblici era in corso di realizzazione. Si trattava di raccogliere l’acqua delle valli di Revolto e Fraselle, confluenti ai piedi di Giazza nel “progno” (torrente) della Val d’Illasi con una galleria di tre metri di diametro scavata in gran parte nella roccia. Più a valle il “vaio” laterale dei Taioli sarebbe stato sbarrato da una diga a gravità e l’acqua d’invaso sarebbe servita a far girare le turbine di una centrale elettrica. Molti già prevedevano uno sviluppo turistico attorno al laghetto che sarebbe nato nella zona di Santa Trinità. Tra loro c’era anche il prete cacciatore che diede inizio alla costruzione di una chiesa più grande. Ma i geologi (forse non erano gli stessi che avevano approvato il progetto) si accorsero che il terreno di natura carsica non era idoneo né al contenimento dell’acqua né a supportare la prevista diga. I chilometri di galleria che avevano sventrato la montagna restano a testimoniare lo sperpero di alcuni miliardi di lire. L’unico lato positivo è costituito dall’incontro di un operaio bellunese con una ragazza del posto conclusosi con il matrimonio. Il parroco di Santa Trinità diffondeva con l’altoparlante il sermoncino serale del mese mariano ai suoi fedeli e a quelli di Sprea in ascolto sul versante opposto della valle.
Il parroco di Selva viene ricordato per il suo impegno sociale. Nell’immediato dopoguerra non è facile trovare lavoro. Lo Stato istituisce i cantieri scuola per lenire la disoccupazione. Approfittando di una legge che finanziava il ripristino delle vecchie strade militari l’amministrazione comunale, su consiglio del parroco, provvide alla ricostruzione dello scomparso fondo stradale per unire il territorio di Velo Veronese a quello di Selva. La paga per gli operai è uno scarso sussidio, che viene integrato con il minestrone preparato nell’asilo parrocchiale e spedito a mezzogiorno via teleferica dal fondo valle. Un giorno il cuoco si è dimenticato di mettervi il sale. E’ facile immaginare le giaculatorie che gli hanno indirizzato gli operai e quelle del giorno dopo per il minestrone salato due volte.
Don Padovani era riuscito ad ottenere dal ministro Rumor, in giro elettorale per racimolare voti anche nelle località più emarginate della montagna veronese, un percussore meccanico per facilitare l’opera dei minatori. E, a strada ultimata, aveva convinto i consiglieri di Giazza ad asfaltare la Velo-Selva prima della loro Selva-Giazza, per la quale non sarebbe stato difficile ottenere in seguito il finanziamento. Il parroco, in tema di strade, sosteneva l’idea di costruire una galleria che mettesse in collegamento la Val d’Illasi, provincia di Verona, con la Val di Ronchi, provincia di Trento. Ha partecipato a tutti i convegni che riguardavano tale progetto, poi abbandonato. La Val d’Illasi ha evitato il pericolo di perdere la sua tranquillità di valle senza sbocco.
Ma don Padovani aveva in mente un altro progetto: costruire una strada che unisse il capoluogo con la frazione di San Bortolo senza passare per il territorio di Badia Calavena. I lavori sono incominciati per finire dopo appena qualche chilometro alla contrada Belvedere. Agli abitanti di San Bortolo bastava la vecchia strada che li faceva scendere a Sant’Andrea. Un altro problema che voleva risolvere ad ogni costo era quello di istituire la scuola media. Era sindaco del Comune il senatore e ministro delle finanze Giuseppe Trabucchi. Ogni volta che arrivava a Selva era sollecitato a sveltire le pratiche burocratiche presso il ministero competente. Dopo tante insistenze era stata approvata l’istituzione. La scuola media sarebbe stata ospitata presso il rinnovato asilo parrocchiale, da qualche anno chiuso per mancanza di bambini.
Don Giuseppe ha visitato le contrade della parte alta del Comune per convincere le famiglie a mandare a scuola i figli. Una madre non era convinta. “Mio figlio viene grande lo stesso” ha esclamato. “Anche il maiale che avete nel porcile viene grosso lo stesso” ha replicato prontamente il sacerdote.
Don Erminio Furlani era il parroco di Giazza, subentrato a don Domenico Mercante, trucidato ad Ala di Trento dai soldati delle SS in ritirata che lo avevano preso in ostaggio. La guerra era finita da pochi giorni. Con don Mercante, vittima innocente, morì anche il soldato tedesco, cattolico, che si era rifiutato di sparare al sacerdote. A Giazza, uno dei più poveri paesi della provincia, era ancora in vita il taucias gareida, l’antico idioma alto tedesco, un tempo diffuso su tutto il territorio dei Tredici Comuni della Lessinia. Anche qui è il parroco a darsi da fare per aiutare i suoi fedeli. Riesce a raccogliere, fuori dalla parrocchia, i soldi necessari per far funzionare una scuola materna nei locali della casa curatale dopo averla dotata di servizi igienici. E pensa di lenire la disoccupazione ottenendo, in seguito ad una lunga e ostinata pressione, l’istituzione di un cantiere scuola da parte del Genio Civile. Decine di allievi, sotto la guida dell’unico scalpellino del luogo, sbozzano migliaia di blocchi di pietra che provengono da una cava di Campofontana per sagomarli in conci adatti a formare il grande volto a copertura del torrente che proviene dalla Val Fraselle.
Giazza ha ora una grande piazza, anche se non proprio piana, dedicata poi al suo ideatore. Per don Erminio il maestro Fabbris, che non mancava di humor, aveva coniato la frase “Ego sum via”. I parrocchiani, più familiarmente, l’avevano soprannominato don Rondina, che rende bene il suo andare con la veste nera svolazzante a cercare aiuti per la sua gente. I parroci di Giazza e Selva, pur occupandosi del bene materiale dei fedeli, non trascurarono il loro ministero pastorale. Certamente non avrebbero potuto ripetere la frase di un loro confratello che al termine del suo incarico disse: “Signore, cavre (capre) mi hai dato e cavre ti rendo”.
Don Candido Celadon, già vicerettore del seminario diocesano, era stato “confinato” a San Bortolo delle Montagne. Era uno di quei preti troppo avanti rispetto alle gerarchie, ancora saldamente legate al pensiero preconcliare. Aveva portato una ventata di aria nuova, risvegliando, in particolare nei giovani, l’interesse per la politica, anche locale. Il segretario generale della Cassa di Risparmio di Verona, che in occasione delle feste natalizie si recava a visitare e a beneficare i poveri della parrocchia, gli fece ottenere in dono un pullmino per il trasporto dei bambini della scuola materna provenienti dalle numerose contrade disseminate nel vasto territorio montano. Per conoscere meglio l’opera di don Celadon, svolta con appassionato impegno non solo sul versante spirituale, lasciamo la parola ad un suo parrocchiano, Beniamino Gaiga, che lo ricorda con infinita gratitudine.
“Don Candido Celadon, destinato alla parrocchia di San Bortolo dalla Curia di Verona, vi giunge nell’estate del 1970 e vi rimane sino al 1976. Trova sui nostri monti una popolazione ricca di tradizioni cristiane ed una terra che ha saputo donare molte vocazioni sacerdotali e religiose. Tutto il popolo partecipa attivamente alla vita della comunità parrocchiale, tutti vivono nelle loro famiglie una vita profondamente cristiana. La vita stessa è scandita da importanti ricorrenze religiose. Il territorio presenta, numerosi segnali e testimonianze religiose: capitelli, croci, colonnette ecc… Quasi la totalità della popolazione vive di agricoltura, allevamento del bestiame, coltivazione dei prati, dei pascoli, taglio dei boschi e trasformazione del latte. I più giovani, proprio in questi anni, iniziano a scendere a valle (valle del Chiampo, valle d’Alpone e val d’Illasi), per entrare nelle fabbriche, nelle industrie, nei laboratori, incontrando nuove realtà, nuovi impulsi , visioni diverse della vita, altri interessi.
Don Candido giunge a San Bortolo nel periodo in cui si comincia a mettere in atto gli insegnamenti e le novità apportate dal Concilio Vaticano II. Notevole è il cambiamento: i fedeli sono chiamati a partecipare alle celebrazioni dei riti religiosi più attivamente, ad avvicinarsi ai sacramenti in modo nuovo. Il cristiano è direttamente coinvolto, diventa più partecipe, più consapevole.
Don Candido è profondamene convinto dell’importanza di questo cambiamento, della portata di tale rinnovamento. Non aspetta, inizia alacremente a coinvolgere la popolazione tutta. Crede che lo spirito del Concilio sia quello di valorizzare la persona, anche la più semplice, la più umile e di avvicinarla a Dio anche attraverso piccoli gesti, nuove e semplici manifestazioni anche esteriori, significative e dimostrative del proprio essere cristiani. Davanti a questi cambiamenti sorgono difficoltà, ostacoli, incomprensioni, ostinazione da parte dei più tradizionalisti e poco disposti al mutamento, al rinnovamento. Pur soffrendo, a volte restando umiliato e non compreso, don Candido non si lascia abbattere e prosegue nel suo intento di promuovere una vita cristiana, vissuta con umiltà, serenità, consapevolezza e, se necessario, con tenacia.
Don Candido, in tutto questo, coinvolge gli alunni delle scuole, si attornia di giovani di numerose persone volonterose, impegnate, fiduciose e desiderose di miglioramento. A tutti loro infonde coraggio, ardore, smussa quella innata timidezza che tanto danno e sofferenza ha arrecato a noi gente di montagna. A tutti imprime il coraggio di esprimere, manifestare le proprie capacità, apprezzare le proprie origini, di riscoprire i valori importanti della vita, i valori di chi vive legato alla terra, alla montagna. Rinsalda la conoscenza, approfondisce il credo cristiano, comunica certezze, rende più consapevoli. Nelle varie attività del paese, e non solo nei momenti di celebrazione di eventi religiosi, coinvolge le famiglie, le contrade, sollecita collaborazione fra queste, cancellando così, a volte, ataviche rivalità o antichi rancori.
Don Candido resta molto vicino agli anziani, conosce la vita, il suo grande valore, la precarietà delle cose; si avvicina ad essi con tanta dolcezza, con un grande sorriso che diventa benedizione. Ascolta, valorizza, promuove serenità, fiducia e speranza, vera speranza. Con entusiasmo ed attenzione ascolta i loro racconti, le loro “storie”, le loro esperienze; lascia che raccontino la loro vita vissuta, le gioie provate, i tanti sacrifici patiti, la guerra, le privazioni e, infine, la ripresa della vita, la ricostruzione materiale delle cose e spirituale degli animi. Don Candido è saggio, profondamente colto, registra nella sua mente i racconti, queste esperienze vissute le fa sue. Comunica gli insegnamenti ai più giovani in modo che l’esperienza degli altri divenga utile a chi si sta preparando a vivere. Nelle omelie, negli incontri con i gruppi, con le famiglie è costante il suo invito a riflettere, ragionare con la propria testa, a saper cogliere il valore ed il significato delle cose. Invita a sforzarsi di camminare con le proprie gambe, a valorizzare le proprie forze, a metterle alla prova, ad irrobustire la volontà, a non lasciarsi trascinare dalle cose, dagli eventi, dagli altri. E’ costante il suo incitamento a tirare fuori le capacità di ognuno, a mostrare le proprie aspirazioni, i propri desideri. Sprona tutti a tirare fuori la grinta assopita per migliorarsi e per migliorare ciò che sta intorno.
Per don Candido la persona è e resta immagine di Dio, qualunque sia la sua condizione sociale, il grado di cultura, il suo ruolo. Per valorizzare la persona don Candido comincia proprio dai “più piccoli” e, instancabilmente, coinvolge le autorità civili e della scuola fino ad ottenere l’istituzione della scuola materna statale a San Bortolo. Lui stesso mette a disposizione alcuni locali della canonica per lo svolgimento delle attività. I genitori sono entusiasti e, con grande sacrificio, a piedi, percorrono ogni giorno molti chilometri di strada per condurre a scuola i ragazzini. La scuola materna, intanto ha inizio, don Candido, sicuro che indietro non si torna, sollecita, pungola le autorità comunali, con costanza, con insistenza e, a volte, con durezza, “quando ci vuole ci vuole”, ottiene che il Comune ristrutturi la scuola materna, iniziata da anni e mai terminata. Così si prodiga affinché vengano eseguiti anche i lavori di sistemazione della scuola elementare di San Bortolo. Si adopera affinché vengano attivati corsi serali per conseguire il diploma della scuola dell’obbligo. Per alcuni giovani il conseguimento del diploma di scuola media è stato molto importante, hanno potuto così accedere a concorsi pubblici banditi presso enti ed inserirsi in ambiti di lavoro prima impensabili e dai quali la gente di montagna era sempre esclusa. Questo, ai nostri giorni, può sembrare insignificante, ma per capirne l’importanza, basta parlare con persone che hanno potuto beneficiarne.
Don Candido è un sacerdote molto colto, dedica tempo allo studio, alla ricerca, al sapere, al conoscere, crede nell’insegnamento, sa che il sapere riscatta la vita, anche la più semplice ed è per questo che, con grande sacrificio si dedica ad insegnare ad alcuni ragazzi più in difficoltà, lontani dalla scuola, sperduti nelle contrade lontane dal paese, che frequentano magari saltuariamente la scuola. Va ad insegnare a questi ragazzi, in queste contrade porta il preside ed alcuni insegnanti affinché si rendano conto delle difficoltà, delle enormi distanze, delle modeste condizioni di vita, per scoraggiare le tante “incomprensioni” degli stessi.
Don Candido è riuscito anche ad entrare nelle simpatie di alcuni ostinatamente lontani-indifferenti alla vita cristiana, alla vita della chiesa; è riuscito a coinvolgerli a renderli da indifferenti a persone attive, partecipi. Questi sono miracoli di chi, non solo crede ed ha una grande fede, ma di chi pone anche grande fiducia nella persona umana e nei suoi fondamentali valori. Ai tanti di noi che, per vari motivi, sono dovuti andare per il mondo, sono dovuti uscire dal “Piccolo mondo..”, don Candido ha saputo inculcare fiducia, coraggio, tenacia consapevolezza, coscienza di aver conseguito, maturato dei valori preziosi, che nessuno, in nessuna circostanza e per nessun motivo può toglierci.
Don Candido ha fatto sì che la nostra timidezza, si trasformi in educazione, rispetto, gentilezza, capacità di ascolto nei confronti di tutti coloro che incontriamo nella vita, La forza della preghiera che lui ci ha sempre insegnato, prima di iniziare ogni giornata, ogni attività, e perché no, anche prima di ogni festa, è diventata coraggio nell’affrontare le difficoltà della vita, è diventata forza che ci aiuta ad inginocchiarci e chiedere umilmente perdono delle nostre fragilità e tenacia nel sapersi rialzare e riprendere con fiducia il cammino. Grazie don Candido, grazie di tutto questo, siamo in molti a dirlo e ad avere la gioia di dirlo.
Ci sono alcuni che sentono il desiderio di ringraziarti perché ti sei adoperato ad infondere loro il coraggio di conseguire, allora, la patente di guida, hai infuso a loro fiducia. Questo semplice documento per un montanaro voleva dire libertà, possibilità di riscatto, comodità di scendere a valle, di essere di aiuto ad altri, di fare la spesa. Diversamente non restava che rimanere prigionieri di questi monti… E’ consapevolezza di tutti che la vita cristiana, il vivere la fede tramandata dai nostri padri, non è un qualche cosa di staccato dalla vita di tutti i giorni, ma ne è parte integrante. Per questo don Candido è vissuto ed ha insegnato a tutti noi a vivere cristianamente, e impegnati socialmente. Si è prodigato per il bene della popolazione ed ha, continuamente, sollecitato e stimolato autorità politiche, amministratori locali, perché vengano realizzate nuove strade, sistemate le esistenti, portato l’acqua, la luce elettrica, in località ancora prive. Si è speso perché vengano migliorati i servizi di trasporto alle persone, perché vengano erogati aiuti alle famiglie, si è interessato a far conseguire la pensione a persone anziane o invalidi.
Credendo nella possibilità di vivere decorosamente in montagna si è interessato affinché venisse aperto un laboratorio tessile ed ha messo a disposizione locali della parrocchia. A tutti noi ha lasciato anche questa certezza di poter vivere quassù, nella semplicità, nella modestia; ci ha insegnato a valorizzare la natura che ci sta intorno, il verde dei nostri boschi, gli spazi sconfinati che possiamo ammirare, le montagne che, poste alle nostre spalle, ci proteggono, i preziosi silenzi che la nostra società ha soffocato e tante, ma tante altre cose. Di don Candido merita ricordare la capacità di valorizzare tutti, ognuno nelle sue peculiarità. Sapeva stare con l’insicuro, con l’incerto, lo rassicurava; sapeva dialogare con il depresso, con lo sfiduciato, con la persona triste, sapeva far sorridere, rincuorare. Sapeva tenere testa al superbo, al troppo sicuro di sé, lo smontava con la sua intelligenza ed il suo sorriso disarmante”.
Don Celadon, che era stato “confinato”, come detto prima, in una parrocchia marginale della montagna veronese, dopo sette anni di attività pastorale viene ancora confinato in una minuscola località, Vanoni Remelli, del Comune di Valeggio sul Mincio. La Curia aveva accolto le rimostranze di alcuni parrocchiani che, non contenti della “rivoluzione” avvenuta nel loro paese per l’opera del sacerdote, lo avevano accusato di aver alienato alcuni arredi sacri.
 La maestrina raggiungeva ogni giorno la scuola partendo dal Giòas, contrada dove abitava
La maestrina raggiungeva ogni giorno la scuola partendo dal Giòas, contrada dove abitava Maria e Aulo Crisma alla prima messa del loro ex-scolaro Agostino Cappelletti.
Maria e Aulo Crisma alla prima messa del loro ex-scolaro Agostino Cappelletti.